Egalitarian Revolution In The Pleistocene?
ScienceDaily (Oct. 3, 2008) — Although anthropologists and evolutionary biologists are still debating this question, a new study supports the view that the first egalitarian societies may have appeared tens of thousands of years before the French Revolution, Marx, and Lenin.
These societies emerged rapidly through intense power struggle and their origin had dramatic implications for humanity. In many mammals living in groups, including hyenas, meerkats, and dolphins, group members form coalitions and alliances that allow them to increase their dominance status and their access to mates and other resources. Alliances are especially common in great apes, some of whom have very intense social life, where they are constantly engaged in a political maneuvering as vividly described in Frans de Waal's "Chimpanzee politics".
In spite of this, the great apes' societies are very hierarchical with each animal occupying a particular place in the existing dominance hierarchy. A major function of coalitions in apes is to maintain or change the dominance ranking. When an alpha male is well established, he usually can intimidate any hostile coalition or the entire community.
In sharp contrast, most known hunter-gatherer societies are egalitarian. Their weak leaders merely assist a consensus-seeking process when the group needs to make decisions, but otherwise all main political actors behave as equal. Some anthropologists argue that in egalitarian societies the pyramid of power is turned upside down with potential subordinates being able to express dominance over potential alpha-individuals by creating large, group-wide political alliance.
What were the reasons for such a drastic change in the group's social organization during the origin of our own "uniquely unique" species? Some evolutionary biologists theorize that at some point in the Pleistocene, humans reached a level of ecological dominance that dramatically transformed the natural selection landscape. Instead of traditional "hostile forces of nature", the competitive interactions among members of the same group became the most dominant evolutionary factor. According to this still controversial view, known as the "social brain" or "Machiavellian intelligence" hypothesis, more intelligent individuals were able to take advantage of other members of their group, achieve higher social status, and leave more offspring who inherited their parent's genes for larger brain size and intelligence. As a result of this runaway process, the average brain size and intelligenc e were increasing across the whole human lineage.
Also increasing were the abilities to keep track of within-group social interactions, to remember friends and their allies and enemies, and to attract and use allies. At some point, physically weaker members of the group started forming successful and stable large coalitions against strong individuals who otherwise would achieve alpha-status and usurp the majority of the crucial resources. Eventually, an egalitarian society was established. Although some of its components are well supported by data, this scenario remains highly controversial. One reason is its complexity which makes it difficult to interpret the data and to intuit the consequences of interactions between multiple evolutionary, ecological, behavioral, and social factors acting simultaneously. It is also tricky to evaluate relevant time-scales and figure out possible evolutionary dynamics.
A new article in PLoS One makes steps towards answering these challenges. The paper is co-authored by Sergey Gavrilets, a theoretical evolutionary biologist, and two computer scientists, Edgar Duenez-Guzman and Michael Vose, all from the University of Tennessee, Knoxville.
The researchers built a complex mathematical model describing the process of alliance formation which they then studied using analytical methods and large-scale numerical simulations. The model focuses on a group of individuals who vary strongly in their fighting abilities. If all conflicts were exclusively between pairs of individuals, a hierarchy would emerge with a few strongest individuals getting most of the resource. However, there is also a tendency (very small initially) for individuals to interfere in an ongoing dyadic conflict thus biasing its outcome one way or another. Positive outcomes of such interferences increase the affinities between individuals while negative outcomes decrease them. Naturally, larger coalitions have higher probability of winning a conflict.
Gavrilets and colleagues identified conditions under which alliances can emerge in the group: increasing group size, growing awareness of ongoing conflicts, better abilities in attracting allies and building complex coalitions, and better memories of past events.
Most interestingly, the model shows that the shift from a group with no alliances to one or more alliances typically occurs suddenly, within several generations, in a phase-transition like fashion. Even more surprisingly, under certain conditions (which include some cultural inheritance of social networks) a single alliance comprising all members of the group can emerge in which resources are divided evenly. That is, the competition among non-equal individuals can paradoxically result in their eventual equality.
Gavrilets and colleagues argue that such an "egalitarian revolution" could also follow a change in the mating system that would increase father-son social bonds or an increase in fidelity of cultural inheritance of social networks. Interestingly, the fact that mother-daughter social bonds are often very strong in apes suggests (everything else being the same) that females could more easily achieve egalitarian societies.
The model also highlights the importance of the presence of outsiders (or "scapegoats") for stability of small alliances. The researchers suggest that the establishment of a stable group-wide egalitarian alliance should create conditions promoting the origin of conscience, moralistic aggression, altruism, and other cultural norms favoring group interests over those of individuals. Increasing within-group cohesion should also promote the group efficiency in between-group conflicts and intensify cultural group selection.
"Our language probably emerged to simplify the formation and improve the efficiency of coalitions and alliances," says Gavrilets. The scientists caution that one should be careful in applying their model to contemporary humans (whether members of modern societies or hunter-gathers). In contemporary humans, an individual's decision to join coalitions is strongly affected by his/her estimates of costs, benefits, and risks associated as well as by cultural beliefs and traditions. These are the factors explicitly left outside of the modeling framework.
In humans, a secondary transition from egalitarian societies to hierarchical states took place as the first civilizations were emerging. How can it be understood in terms of the model discussed? One can speculate that technological and cultural advances made the coalition size much less important in controlling the outcome of a conflict than the individuals' ability to directly control and use resources (e.g. weapons, information, food) that strongly influence the outcomes of conflicts.
Journal reference:
1. Gavrilets et al. Dynamics of Alliance Formation and the Egalitarian Revolution. PLoS ONE, 2008; 3 (10): e3293 DOI: 10.1371/journal.pone.0003293
Adapted from materials provided by Public Library of Science, via EurekAlert!, a service of AAAS.
lunedì 6 ottobre 2008
Egalitarian Revolution In The Pleistocene? ScienceDaily (Oct. 3, 2008)
giovedì 31 luglio 2008
Alba d'Inchiostro

Qual'è il desiderio più grande quando si ama moltissimo un libro? Si vorrebbe entrarci dentro.
Questo non è solamente un sogno per Mortimer, il rilegatore, sua figlia Meggie e sua moglie Resa. E se la storia sfuggisse al controllo del suo scrittore? E se il personaggio che si interpreta lentamente prendesse il posto della persona che si era? E' questo il dubbio di Meggie, che dentro suo padre, ormai, non vede più in Mortimer il "Medico dei libri", ma il brigante Glandarius, il soldato, l'assassino al servizio del bene, che lotta insieme al Principe Nero contro la tirannia di Testa di Serpente.
E se lo scrittore non fosse più capace di scrivere? Fenoglio ha le parole dentro la testa, ma non riesce più a combinarle insieme nel creare una fantastica storia. Il vile Orfeo ha preso il suo posto come scrittore del Mondo d'Inchiostro, potendo però solo rimescolare le parole scritte da Fenoglio per comporre nuovi testi. Ma Orfeo ha anche i suoi vantaggi. E' anche lui, come Meggie e suo padre, una "Lingua di Fata", così infatti vengono chiamate le persone che leggendo tramutano le lettere scritte sulla carta in realtà. Il vile scrittore usa però i suoi poteri per procurarsi richezze e celebrità, invece che per il bene comune. Ed è così che cerca di uccidere Mortimer/Glandarius, consegnandoli un testo per far tornare dal regno dei morti Dita di Polvere. Ma non riesce nel suo intento, i due tornano emtrambi sani e salvi, anche se sulla testa del rilegatore/brigante grava un terribile giramento: se non riuscirà a uccidere Testa di Serpente prima dell'avvento della primavera, le Dame Bianche, spiriti di morte, se lo porteranno via, insieme a Meggie e a Dita di Polvere.
Fra un'alleanza segreta con Violante, la figlia del nemico, e Resa che si trasforma in rondine insieme al bambino che aspetta, Mortimer ritrova il suo passato nel mestiere del rilegatore, dovendo, infatti, realizzare un libro che tenga in vita Testa di Serpente, malato e ad un passo della morte. Grazie al provvidenziale ed inaspettato aiuto di Jacopo, l'insopportabile e saccente figlio di Violante, riesce a uccidere Testa di Serpente, garantendo pace e serenità nel Mondo d'Inchiostro.
E' un libro sull'amore, sulla necessità di avere un ruolo in una storia, sul coraggio, sulla lealtà, sull'amicizia.
Cuore d'Inchiostro

E se i personaggi di un libro che amate particolarmente entrassero nella vostra vita, sconvolgendola? E se in cambio cadesse nel loro mondo una persona a cui volete bene? E se tutto ciò accadesse a causa della vostra voce? Se, leggendo, riusciste a dare alle parole quell'emozione, quell'intonazione giusta per fare si che si avverino? Tutto questo accade a Mortimer Flochart, un rilegatore, un "Medico dei libri". La moglie scompare in un libro fantasy, e al suo posto compaiono nel salotto di casa tre personaggi. Ma non tutti vogliono tornare nel loro mondo. Dita di Polvere, il mangiafuoco, ne sente una grande nostalgia, ed è pronto a tutto per tornare indietro. Ma il crudele e perverso Capricorno, con il suo superstizioso luogotenente Basta, non sono della stessa opinione. Sono decisi a far scomparire dalla faccia della terra ogni copia del libro da cui provengono, in modo di non tornarci mai più. Ma Mortimer ne conserva ancora una copia. Infatti non ha mai perso la speranza del ritorno di sua moglie. Ed è così che lui, la figlia Meggie e un'anziana e bisbetica prozia di nome Elinor vengono trascinati in un'avvincente avventura, accompagnati dal volubile Dita di Polvere, sempre deciso a tornare indietro, e da Farid, un ragazzo uscito dalle Mille e una Notte. Dalla penna di Cornelia Funke, definita da The Times la "Rowling tedesca", un romanzo di avventura, misteri, amore e un'infinita passione per la lettura, che vede i libri non come semplici lettere scritte sulla carta, ma come esseri viventi, che donano emozioni e gioia. Avrete il coraggio, dopo, di leggere ancora un libro a voce alta?
sabato 28 giugno 2008
Barack Obama, I sogni di mio padre, Nutrimenti, Roma 2007 (prima ed. 1995), pp. 460.
 Barack Obama, I sogni di mio padre, Nutrimenti, Roma 2007 (prima ed. Dreams from my father, New York 1995), pp. 460.
Barack Obama, I sogni di mio padre, Nutrimenti, Roma 2007 (prima ed. Dreams from my father, New York 1995), pp. 460.Più che una recensione, questa scheda vuole essere un invito alla lettura. Si tratta dell’autobiografia di Barack Obama, un’autobiografia veramente bella, e soprattutto autentica: trovo importante sottolineare le coordinate cronologiche del libro, scritto molto prima dell’impegno di Obama per la casa Bianca. Il dato ci permette di non dover temere l’ombra della propagando dietro ogni parola letta, e di potercela invece gustare per quello che essa semplicemente è e dice: la storia di un uomo che cerca se stesso.
Il libro assume quasi la forma di un romanzo, e molto spesso, preso dalla lettura - veramente coinvolgente - il lettore corre il rischio di dimenticare che di autobiografia si tratta e non di romanzo, non di fizione. E questo accade sia per il carattere avventuroso di tutta la prima e la terza parte (l’infanzia di Barack in Indonesia, la prima adolescenza alle Hawaii, il college in California, i viaggi nella profonda Africa), sia per la profondità e l’analiticità con cui i vari personaggi sono introdotti e descritti. Per la profondità e l’analiticità con cui l’autore indaga e sviscera se stesso, le proprie paure, i propri timori, i propri abissi. Ma in effetti sì, si tratta anche di un romanzo, a volerla dire tutta. Un romanzo di formazione, in cui Barack percorre la lunga e dolorosa strada che conduce alla consapevolezza di sé: sentendosi estraneo sia al mondo dei neri, sia a quello dei bianchi, Barack lotta per capire chi è, per trovare la propria identità, per autodefinirsi, mentre si sente a disagio in tutti i contesti, in tutte le scelte di vita, perché si rende conto, con incredibile onestà intellettuale, che ognuna di queste vie era in realtà una fuga, una fuga da se stesso e dalle proprie radici.
Bellissimo il ritratto che emerge, pagina dopo pagina, del rapporto a distanza (un vero e proprio rapporto nella mente) con suo padre, visto solo una volta, da piccolo, eppure così presente nella sua vita. Un vero e proprio “mito”, che peserà come un macigno su tutta la vita di Obama, sia quando sarà figura di perfezione e integrità su di un alto piedistallo, sia quando si mostrerà non all’altezza di quella mitografia e di quel piedistallo, provocando in Barack delusione e rabbia.
Il libro prende le mosse proprio dal momento cruciale di questo cammino: la telefonata che dalla lontana Africa gli annuncia, a 21 anni, che suo padre è morto. A quel punto inizia il grande flashback che copre tutta la prima parte del libro, un flashback in cui Barack ripercorre la storia della sua famiglia materna, la propria infanzia con i nonni, il mito del padre, tornato in Kenya poco dopo la sua nascita, i primi anni trascorsi alle Hawaii, e poi il trasferimento in Indonesia, con la madre e il suo nuovo compagno, per poi tornare alle Hawaii dai nonni, e poi al college di Los Angeles. Il processo di formazione vero e proprio inizia con la scuola, ovviamente, perché è la relazione coi coetanei a generare le domande, sono gli altri che incarnano elucubrazioni e dilemmi che altrimenti noi saremmo capaci di tacerci e di soffocare per anni, forse per sempre. Sono gli altri che tirano fuori la rabbia e il dolore e le insicurezze e le paure e soprattutto le menzogne che altrimenti manterremmo al fondo della nostra anima. Dalla bambina di colore nel cortile della scuola elementare (che Barack maltratta per non essere emarginato dai compagni bianchi), ai “fratelli” di lotta negli anni di Università, ognuno di queste comparse, con un gesto, una parola, un rimprovero, una battuta, aggiunge un tassello fondamentale nel percorso di Obama alla scoperta della propria vera identità. Questo processo di formazione continua durante l’anno di attività a Chicago come coordinatore, un anno trascorso nei quartieri poveri della città, dove le famiglie dei neri vivevano abbandonate a loro stesse, per concludersi, finalmente, con il viaggio in Africa. Dopo aver incontrato, negli Usa, la sorella Auma e il fratello Roy (stesso padre di Obama, ma madre diversa), Barack decide che è giunta l’ora di andare in Kenya, e più precisamente nel villaggio dove era nato e cresciuto suo padre, per conoscere finalmente la sua famiglia, l’altra parte di sé. Le ultime 100, 150 pagine narrano di questo viaggio, delle bellezze selvagge dei luoghi, delle tradizioni, della gente, della storia di un intero popolo che gli viene raccontata di bocca in bocca, dalle vecchie zie, dalla nonna, da parenti più o meno lontani, cui è legato tramite complicatissimi intrecci di sangue e di matrimoni. Ognuno di questi incontri, ognuno di questi colloqui costituiscono un tassello in più nel puzzle che sta mettendo insieme il giovane Barack, fino a quando egli stesso sente che il cerchio si sta finalmente chiudendo, e che finalmente riesce a riconoscere se stesso, nella propria interezza.
Un libro molto molto bello, che ha la precisione del documentario e la bellezza del romanzo. Un libro che ci fa sperare con ancora più desiderio e più audacia che un uomo come Barack Obama, con i suoi trascorsi, con la sua intelligenza, con la sua sensibilità, con la sua integrità, con la sua onestà intellettuale, possa divenire il nuovo Presidente degli Stati Uniti.
Il libro assume quasi la forma di un romanzo, e molto spesso, preso dalla lettura - veramente coinvolgente - il lettore corre il rischio di dimenticare che di autobiografia si tratta e non di romanzo, non di fizione. E questo accade sia per il carattere avventuroso di tutta la prima e la terza parte (l’infanzia di Barack in Indonesia, la prima adolescenza alle Hawaii, il college in California, i viaggi nella profonda Africa), sia per la profondità e l’analiticità con cui i vari personaggi sono introdotti e descritti. Per la profondità e l’analiticità con cui l’autore indaga e sviscera se stesso, le proprie paure, i propri timori, i propri abissi. Ma in effetti sì, si tratta anche di un romanzo, a volerla dire tutta. Un romanzo di formazione, in cui Barack percorre la lunga e dolorosa strada che conduce alla consapevolezza di sé: sentendosi estraneo sia al mondo dei neri, sia a quello dei bianchi, Barack lotta per capire chi è, per trovare la propria identità, per autodefinirsi, mentre si sente a disagio in tutti i contesti, in tutte le scelte di vita, perché si rende conto, con incredibile onestà intellettuale, che ognuna di queste vie era in realtà una fuga, una fuga da se stesso e dalle proprie radici.
Bellissimo il ritratto che emerge, pagina dopo pagina, del rapporto a distanza (un vero e proprio rapporto nella mente) con suo padre, visto solo una volta, da piccolo, eppure così presente nella sua vita. Un vero e proprio “mito”, che peserà come un macigno su tutta la vita di Obama, sia quando sarà figura di perfezione e integrità su di un alto piedistallo, sia quando si mostrerà non all’altezza di quella mitografia e di quel piedistallo, provocando in Barack delusione e rabbia.
Il libro prende le mosse proprio dal momento cruciale di questo cammino: la telefonata che dalla lontana Africa gli annuncia, a 21 anni, che suo padre è morto. A quel punto inizia il grande flashback che copre tutta la prima parte del libro, un flashback in cui Barack ripercorre la storia della sua famiglia materna, la propria infanzia con i nonni, il mito del padre, tornato in Kenya poco dopo la sua nascita, i primi anni trascorsi alle Hawaii, e poi il trasferimento in Indonesia, con la madre e il suo nuovo compagno, per poi tornare alle Hawaii dai nonni, e poi al college di Los Angeles. Il processo di formazione vero e proprio inizia con la scuola, ovviamente, perché è la relazione coi coetanei a generare le domande, sono gli altri che incarnano elucubrazioni e dilemmi che altrimenti noi saremmo capaci di tacerci e di soffocare per anni, forse per sempre. Sono gli altri che tirano fuori la rabbia e il dolore e le insicurezze e le paure e soprattutto le menzogne che altrimenti manterremmo al fondo della nostra anima. Dalla bambina di colore nel cortile della scuola elementare (che Barack maltratta per non essere emarginato dai compagni bianchi), ai “fratelli” di lotta negli anni di Università, ognuno di queste comparse, con un gesto, una parola, un rimprovero, una battuta, aggiunge un tassello fondamentale nel percorso di Obama alla scoperta della propria vera identità. Questo processo di formazione continua durante l’anno di attività a Chicago come coordinatore, un anno trascorso nei quartieri poveri della città, dove le famiglie dei neri vivevano abbandonate a loro stesse, per concludersi, finalmente, con il viaggio in Africa. Dopo aver incontrato, negli Usa, la sorella Auma e il fratello Roy (stesso padre di Obama, ma madre diversa), Barack decide che è giunta l’ora di andare in Kenya, e più precisamente nel villaggio dove era nato e cresciuto suo padre, per conoscere finalmente la sua famiglia, l’altra parte di sé. Le ultime 100, 150 pagine narrano di questo viaggio, delle bellezze selvagge dei luoghi, delle tradizioni, della gente, della storia di un intero popolo che gli viene raccontata di bocca in bocca, dalle vecchie zie, dalla nonna, da parenti più o meno lontani, cui è legato tramite complicatissimi intrecci di sangue e di matrimoni. Ognuno di questi incontri, ognuno di questi colloqui costituiscono un tassello in più nel puzzle che sta mettendo insieme il giovane Barack, fino a quando egli stesso sente che il cerchio si sta finalmente chiudendo, e che finalmente riesce a riconoscere se stesso, nella propria interezza.
Un libro molto molto bello, che ha la precisione del documentario e la bellezza del romanzo. Un libro che ci fa sperare con ancora più desiderio e più audacia che un uomo come Barack Obama, con i suoi trascorsi, con la sua intelligenza, con la sua sensibilità, con la sua integrità, con la sua onestà intellettuale, possa divenire il nuovo Presidente degli Stati Uniti.
Alessandra
sabato 14 giugno 2008
"Operazione Odessa" di Uki Goñi, Milano Garzanti 2003 (rist. 2008)
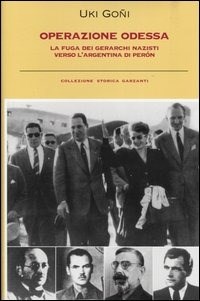
Mat
Un libro istruttivo su un momento particolare della storia del '900, purtroppo sconosciuto ai più; la storia, ricostruita nei limiti del possibile, della "fuga" (si può chiamare fuga un esodo di massa?) di gerarchi nazisti, "collaborazionisti", interi governi e semplici uomini di credo ultranazionalista e generalmente antisemita (e non solo) dall'Europa del primo dopoguerra verso un Paese teoricamente neutrale (anzi, negli ultimi sviluppi del conflitto schierato con gli Alleati): l'Argentina.
L'autore del libro, figlio di un ambasciatore Argentino durante il periodo dei fatti narrati, ripercorre la realizzazione dell'"impresa" delle diverse reti di salvataggio appoggiate da Peron e dal suo entourage con la connivenza di settori della Chiesa Cattolica (sia a Roma e Genova che in Argentina che in Spagna) e per diverse ragioni, a volte, dei servizi segreti di diverse nazioni vincitrici (Inghilterra e Stati Uniti sopra tutte). Lo spaccato che ne esce (incompleto di parte delle fonti documentarie del servizio di immigrazione argentino, eliminato in diversi periodo storici, quasi fino ai giorni nostri) rende l'idea di quanto ramificati e incredibili siano stati (e siano ancora oggi) gli intrecci tra politica, idealismo religioso (e non solo), potere economico, scontro tra potenze nel dopoguerra e di quanto per motivi assolutamente futili molti criminali condannati siano stati in realtà parte integrante della vita politico-economica e culturale di uno stato per decenni.
Solo negli ultimi anni l'Argentina ha accettato di estradare alcuni criminali dichiarati colpevoli (tra cui in Italia ricordiamo il caso Priebke), forse anche per cominciare a rivedere la propria storia in modo più critico, ma ciò non toglie che per decenni un alto numero di persone ricercate hanno potuto vivere e continuare ad esporre i propri credo liberamente.
Uno dei tanti episodi poco conosciuti della nostra storia moderna, un momento per riflettere su quanto motivi di pura convenienza incidano in realtà sull'andamento della vita nel nostro paese e nel mondo intero.
L'autore del libro, figlio di un ambasciatore Argentino durante il periodo dei fatti narrati, ripercorre la realizzazione dell'"impresa" delle diverse reti di salvataggio appoggiate da Peron e dal suo entourage con la connivenza di settori della Chiesa Cattolica (sia a Roma e Genova che in Argentina che in Spagna) e per diverse ragioni, a volte, dei servizi segreti di diverse nazioni vincitrici (Inghilterra e Stati Uniti sopra tutte). Lo spaccato che ne esce (incompleto di parte delle fonti documentarie del servizio di immigrazione argentino, eliminato in diversi periodo storici, quasi fino ai giorni nostri) rende l'idea di quanto ramificati e incredibili siano stati (e siano ancora oggi) gli intrecci tra politica, idealismo religioso (e non solo), potere economico, scontro tra potenze nel dopoguerra e di quanto per motivi assolutamente futili molti criminali condannati siano stati in realtà parte integrante della vita politico-economica e culturale di uno stato per decenni.
Solo negli ultimi anni l'Argentina ha accettato di estradare alcuni criminali dichiarati colpevoli (tra cui in Italia ricordiamo il caso Priebke), forse anche per cominciare a rivedere la propria storia in modo più critico, ma ciò non toglie che per decenni un alto numero di persone ricercate hanno potuto vivere e continuare ad esporre i propri credo liberamente.
Uno dei tanti episodi poco conosciuti della nostra storia moderna, un momento per riflettere su quanto motivi di pura convenienza incidano in realtà sull'andamento della vita nel nostro paese e nel mondo intero.
Mat
lunedì 9 giugno 2008
“Come le mosche d’autunno” di Irène Némirovsky, Adelphi - Milano 2007
 In questo racconto lungo la Némirovsky affronta il tema, certamente autobiografico, dello sradicamento dell’essere umano dalla sua terra d’origine e dalla sua origine, e del violento trapianto in un altro luogo. È il caso di una benestante famiglia russa, i Karin, che allo scoppio della rivoluzione bolscevica si trasferisce in Francia. Con essi è Tat’jana Ivanovna, la vecchia nutrice, la vera protagonista del racconto perché custode della memoria di quella famiglia e della sua identità. È lei che da almeno tre generazioni conserva i segreti, i gesti, i sentimenti, gli eventi di quella comunità. È lei che vede uccidere uno di loro in nome del nuovo ordine rivoluzionario. È lei che custodisce la casa dopo la fuga dei Karin ad Odessa, in luoghi più sicuri. È lei a raccogliere gli ori di famiglia e consegnarli ai suoi padroni perchè tutti si trasferiscano in Francia. È lei che a Parigi, nel nuovo mondo, li vede malinconicamente senza radici e memoria, proprio Come le mosche d’autunno che sbattono contro i vetri delle case volteggiando con le ali incerte, prossime ormai alla fine.
In questo racconto lungo la Némirovsky affronta il tema, certamente autobiografico, dello sradicamento dell’essere umano dalla sua terra d’origine e dalla sua origine, e del violento trapianto in un altro luogo. È il caso di una benestante famiglia russa, i Karin, che allo scoppio della rivoluzione bolscevica si trasferisce in Francia. Con essi è Tat’jana Ivanovna, la vecchia nutrice, la vera protagonista del racconto perché custode della memoria di quella famiglia e della sua identità. È lei che da almeno tre generazioni conserva i segreti, i gesti, i sentimenti, gli eventi di quella comunità. È lei che vede uccidere uno di loro in nome del nuovo ordine rivoluzionario. È lei che custodisce la casa dopo la fuga dei Karin ad Odessa, in luoghi più sicuri. È lei a raccogliere gli ori di famiglia e consegnarli ai suoi padroni perchè tutti si trasferiscano in Francia. È lei che a Parigi, nel nuovo mondo, li vede malinconicamente senza radici e memoria, proprio Come le mosche d’autunno che sbattono contro i vetri delle case volteggiando con le ali incerte, prossime ormai alla fine.Ma mentre i Karin, come molti altri esuli russi, si adattano a quel mondo diverso, cercando in ogni modo di ricostruirsi una vita, Tat’jana Ivanovna no. Al contrario dei nobili che si improvvisano borghesi, lei, contadina, legata alla terra, avverte in questo cedimento una morte dell’anima, alla quale non sa rassegnarsi. Le mancano le cose elementari, quelle con le quali è cresciuta, si è formata la sua esistenza: la neve per esempio, il bisogno di vedere il paesaggio entro il quale è trascorsa la vita, di respirare l’aria della sua terra, di contemplarne il cielo, di sentire il calore della stufa così diverso da quello dei caloriferi che non hanno nessun rapporto diretto col fuoco. Ma Tat’jana Ivanovna avverte che in quella casa è diventata un peso, senza più quel ruolo, che faceva di lei il centro vitale della famiglia, si sente persa, disorientata. La memoria che stentatamente cerca di rievocare nei Kalin, non trova corrispondenze, sembra per loro un fardello di cui liberarsi al più presto. E questa lontananza dalla terra d’origine, unitamente al distacco dal mondo affettivo dei Karin, le fanno immaginare, proprio il giorno di Natale, quando gli altri sono altrove a festeggiare, che quella nebbia che avvolge la città sia la neve tanto attesa come quella di Sucharevo e la Senna, dove incautamente s’avventura, sia una distesa ghiacciata al di là della quale c’è la sua Karinovka.
È un piccolo capolavoro per chi si lascia affascinare dalla forza vitale della memoria anche se dolorosa ed anche per chi è amante di quel nomadismo che per destino gli scrittori di origine ebrea interpretano così profondamente. È quel nomadismo che non ti fa sentire mai a casa tua, una specie di estraneità al mondo in cui si vive per riandare alle origini, in cammino verso là dove pensiamo di incontrare l’essere umano. Come le mosche d’autunno è un racconto che raccomando di leggere anche per la qualità della scrittura asciutta, essenziale, che non cede mai al superfluo, ma non per questo meno capace di riprodurre atmosfere, ambienti, riflessioni. Un ottimo avvio alla lettura di Suite francese che è il vero capolavoro della Némirovsky.
sabato 31 maggio 2008
“Firmino” di Sam Savage - Einaudi, Torino 2008
 Cosa succede quando la metafora, da figura retorica, appartenente cioè al linguaggio dell’immaginazione, si trasforma improvvisamente nella realtà di cui rappresenta la figurazione? Nasce la fabula, quella narrazione tra realtà ed immaginazione, dove, come dice Sam Savage, “le vite hanno sempre un significato e un fine”, anche quelle che nella vita reale sembrano non averne alcuno. È il caso di questo romanzo di Sam Savage che invito a leggere perché suggerisce, al di là della storia che tuttavia ti prende dall’inizio alla fine, molte interessanti riflessioni su quel complesso fenomeno che è la letteratura.
Cosa succede quando la metafora, da figura retorica, appartenente cioè al linguaggio dell’immaginazione, si trasforma improvvisamente nella realtà di cui rappresenta la figurazione? Nasce la fabula, quella narrazione tra realtà ed immaginazione, dove, come dice Sam Savage, “le vite hanno sempre un significato e un fine”, anche quelle che nella vita reale sembrano non averne alcuno. È il caso di questo romanzo di Sam Savage che invito a leggere perché suggerisce, al di là della storia che tuttavia ti prende dall’inizio alla fine, molte interessanti riflessioni su quel complesso fenomeno che è la letteratura.Firmino è un vero e proprio topo non di biblioteca ma di libreria, che, ultimo di una nidiata di tredici topolini, deve la sua sopravvivenza allo sbriciolamento delle pagine dei libri che lo nutrono e gli forniscono i rudimenti della cultura umana. Così imparato l’alfabeto si dedica allo studio delle parole e quindi alla lettura vorace di libri di ogni genere identificandosi con i grandi eroi della letteratura di ogni tempo, e acquisendo una conoscenza enciclopedica che va dalla filosofia, alla politica, dalla storia alla geografia, alla manualistica di ogni tipo. Ma scopre anche che i libri più belli sono i più buoni, quelli che fanno crescere il corpo e arricchiscono l’anima! I libri così acquisiti, da autodidatta, senza un piano di studio, sono nutrimento del pensiero, gli offrono la possibilità di associare quanto letto alla realtà e viceversa, di conoscere se stessi e il mondo. Insomma con la lettura Firmino si costruisce come persona e come personaggio, come essere protagonista sia della propria vita che della storia che viene narrando.
Savage ci mette di fronte ad una storia singolare per il punto di osservazione, per i desideri che suscita e per gli esiti che consegue. Vedere il mondo attraverso gli occhi di un topo, che possiede, per giunta, una cultura umana ed umanistica consente all’autore un giudizio incolpevole e spietato sulla società del nostro tempo, su quegli aspetti aberranti del mondo moderno dimentico dell’umano e creatore di emarginazioni e solitudini. Ma è un mondo che solo i libri possono salvare, quasi che una nuova classe sociale, quella dei lettori, si assuma il fardello di riscattare l’umanità dalle proprie ignoranze.
Ma Firmino è anche un essere sospeso tra il rifiuto di considerarsi topo e di vivere da topo in mezzo agli altri topi, e il desiderio suo, di topo umanizzato, di comunicare con gli uomini. Impresa impossibile, anche se Firmino si illude che almeno in parte gli sia riuscita facendosi, per così dire, adottare da un solitario quanto stravagante scrittore. È in fondo, a veder bene, il destino di chi fa della scrittura il centro della propria vita. Per sapere interpretare i sogni e i bisogni degli uomini e restituirli loro nelle forme della poesia occorre avere una conoscenza dell’universo umano la più ampia possibile che è data certo dalla curiosità e dall’osservazione, ma anche e soprattutto dalla dimestichezza con quanto gli uomini prima di lui hanno scritto, che è come un prender le distanze, come un estraniarsi al tempo in cui si vive. Lo scrittore è in bilico tra l'essere nel mondo senza essere del mondo. Così la classe dei lettori si allarga agli scrittori, quasi a ricreare quella comunità di spiriti un tempo detta Repubblica delle Lettere.
Infine gli esiti straordinari di questa breve (quanto può esserlo la vita di un topo) esistenza che man mano vede allargarsi gli orizzonti delle conoscenze, ampliarsi la gamma dei sentimenti, arricchirsi il linguaggio. Ma, grazie anche alle passioni per il cinema e la musica, a svilupparsi è soprattutto la fantasia: quel pensiero che travalica il limite oggettivo, reale del suo essere topo per elevarlo nello spazio e nel tempo dell’immaginario. “(…) talvolta [dice Firmino] avevo preso a giocare con il passato, forzandolo, facendo qua e là tanti piccoli aggiustamenti per renderlo più simile a una storia vera, e avevo anche cominciato a mescolare i ricordi con i sogni”.
In questo magma indistinto di memoria ed immaginazione nasce l’urgenza della scrittura. Infatti l’approdo finale al miracolo del libro scritto, della sua autobiografia, che è poi il romanzo che stiamo leggendo, ahimè, coincide con la sua fine. La scoperta che i coriandoli di libri non solo lo hanno nutrito nel corpo e nello spirito, ma hanno prodotto e continuano a produrre, anche in questi istanti ultimi di vita, qualcosa di umano, come un libro, trasforma la sua morte in un atto epico, eroico con cui si chiude contemporaneamente il romanzo e la vita. E mentre intorno crolla l’antico quartiere di Boston dove è la libreria che lo ha nutrito ed ospitato per far posto, sul deserto della spianata, ad un’anonima piazza o centro commerciale, la morte coglie Firmino in un monologo di sapore shakespeariano che si traduce nella pagina scritta del commiato dal mondo e da noi lettori che lo interpretiamo. È una pagina di straordinaria passione per quell’umanità autentica di cui ha preso coscienza anche se raramente l’ha potuta incontrare. “«Ma detesto quelli che sono qui, e detesto tutti. Pazzo nella mia solitudine. Per tutte le loro colpe. Sto perdendo i sensi. Oh, amara fine! Loro non se ne accorgeranno mai. Né lo sapranno. Né sentiranno la mia mancanza. E tutto è vecchio e vecchio tutto triste e vecchio tutto triste e stanco». Fissai le parole. Non galleggiavano davanti ai miei occhi né si offuscavano. I ratti non hanno lacrime. Arido e freddo era il mondo, e le parole meravigliose. Le parole arrivederci e addio, addio e ci vediamo, pronunciate dal piccolo e dal Grande. Tornai a ripiegare il brano e lo mangiai.”
mercoledì 28 maggio 2008
La taverna del doge Loredan
 La storia parla di un editore veneziano che "casualmente" trova in cima a un armadio un libro senza titolo e autore.
La storia parla di un editore veneziano che "casualmente" trova in cima a un armadio un libro senza titolo e autore.Incuriosito inizia a leggerlo e scopre che, ambientato in Inghilterra in un'altra epoca, ha per protagonista un giovane libertino.
Le due storie (dell'editore e del giovane inglese) procedono inizialmente parallele poi...
Le parti di lettore, scrittore, protagonista si mischiano tra avventure, intrighi e amori piu' o meno avvincenti, e soprattutto questa misteriosa promiscuita' di ruoli rende il libro interessante e meritevole di essere letto.
martedì 20 maggio 2008
“Diario di scuola” di Daniel Pennac – Feltrinelli, Milano 2008
 Quando si scrive di scuola e delle carenze vistose che contraddistinguono l’istituzione per eccellenza deputata alla formazione delle nuove generazioni si corre il rischio di due eccessi: la generalizzazione dei problemi che escludono la fattispecie in cui quell’insegnante e quegli studenti si trovano, e la singolarità delle esperienze, penso ad esempio, alla scuola di Barbiana di Don Milani, o all’esperienza di Albino Bernardini raccolta in Un anno a Pietralata, che proprio perché particolari, sono irripetibili, e difficilmente raggiungono il livello della generalità. Diario di scuola è un’opera che si muove entro questi due confini: per un verso essa è la declinazione al singolare dell’esperienza scolastica prima dello studente e poi dell’insegnante Daniel Pennac, per l’altro via via che si va verso la conclusione la singolarità si coniuga con la riflessione più generale, e coinvolge le macrostrutture sociali, culturali (molto efficace ad esempio è l’analisi dello studente cliente) entro le quali la scuola (insegnanti, studenti e famiglie) viene ad operare.
Quando si scrive di scuola e delle carenze vistose che contraddistinguono l’istituzione per eccellenza deputata alla formazione delle nuove generazioni si corre il rischio di due eccessi: la generalizzazione dei problemi che escludono la fattispecie in cui quell’insegnante e quegli studenti si trovano, e la singolarità delle esperienze, penso ad esempio, alla scuola di Barbiana di Don Milani, o all’esperienza di Albino Bernardini raccolta in Un anno a Pietralata, che proprio perché particolari, sono irripetibili, e difficilmente raggiungono il livello della generalità. Diario di scuola è un’opera che si muove entro questi due confini: per un verso essa è la declinazione al singolare dell’esperienza scolastica prima dello studente e poi dell’insegnante Daniel Pennac, per l’altro via via che si va verso la conclusione la singolarità si coniuga con la riflessione più generale, e coinvolge le macrostrutture sociali, culturali (molto efficace ad esempio è l’analisi dello studente cliente) entro le quali la scuola (insegnanti, studenti e famiglie) viene ad operare.Pennac ripercorre in questo diario il proprio itinerario scolastico secondo la duplice prospettiva dello studente prima somaro e poi recuperato, e quindi di insegnante che di proposito sceglie di dedicarsi al recupero alla dignità di persone e di studenti dei tanti somari, in gran parte coincidenti con i bulli, con i fascisti dell’ignoranza, che popolano le cronache scolastiche di oggi. È un percorso iniziato nell’infanzia quando lui nato da una famiglia benestante, ultimo di quattro fratelli laureati a pieni voti e figlio di professionisti, si scopre presto refrattario alla conoscenza, all’assimilazione dei concetti, alla memorizzazione. Scopre il suo senso di impotenza e inadeguatezza, al quale sopperisce con incredibili e sfacciate bugie dette alla famiglia e agli insegnanti, in una spirale da cui spesso si esce solo con l’abbandono scolastico. A meno di non incontrare un insegnante capace di salvarlo dalla condizione di ignorante impenitente. Un insegnante di francese (il nostro insegnante di Lettere) che, di fronte alla nullità del rendimento scolastico e alla sua capacità inesauribile di inventare scuse fantasiose, addotte a giustificare la propria somaraggine, lo impegna a scrivere racconti, a dare sfogo alla sua abilità ad inventare storie. E poi l’incontro con l’amore che agita l’anima e il corpo dell’adolescente. L’amore infatti implica la scoperta del valore di sé agli occhi dell’altro. Esso avvia quell’autostima senza la quale è impossibile qualsiasi riscatto. Così la metamorfosi da somaro a somaro redento è affidata alla scoperta della scrittura come vocazione, come bisogno di dare corpo al pensiero ed alla fantasia, e a quella dell’amore che ti pone di fronte all’altro, al tu che spezza definitivamente il muro entro cui è confinata la solitudine del somaro.
Esperienza drammatica quella dell’insuccesso scolastico che lascia i suoi segni, ma che fa nascere anche la consapevolezza che la somaraggine non è un destino ineludibile, essa è una condizione dalla quale è possibile uscire se solo si ha la fortuna di incontrare l’insegnante giusto. Questa idea, della possibile sconfitta della così detta somaraggine, diviene lo scopo di una missione: salvare il più possibile i ragazzi votati alla morte scolastica. Missione che finalizza la vita di Pennac ad insegnare ad imparare e, dove possibile, a far sì che chi impara possa a sua volta insegnare, diventare lui stesso maestro accogliendo il testimone di una corsa senza fine contro il pregiudizio scolastico.
Tutte le missioni sono fondate sull’amore gratuito di quello che si fa. Ed è la prima cosa che gli studenti di una classe percepiscono di te insegnante. Se sei o meno innamorato del tuo lavoro. Se sei lì davanti a loro perché docente investito di un ruolo, di una funzione, di un’autorità e quindi di un potere, o se invece ti appassioni a quello che dici, se stai trasmettendo non una materia scolastica, ma una parte di te, di come tu intendi quel tuo sapere. Essi si abituano a vedere con i tuoi occhi, ad ascoltare con i tuoi orecchi, a comprendere con la tua intelligenza. Essi sono dotati di quella sensibilità coinvolgente che li impegna a restituire in proporzione di quanto è stato loro donato. È questa originaria e imprescindibile passione che fa di un professore un insegnante, di un docente un maestro. Maestro ed allievo sono i due termini più propri ad indicare il complesso fenomeno dell’educazione scolastica. Maestro, dal latino magister, ha in sé la radice magis, che significa un di più, nel senso doppio in riferimento sia alla persona, cioè a colui che è di più rispetto all’allievo, sia al suo fare, al suo far crescere, ad-levare, cioè portare in alto chi ha bisogno di essere aiutato ad essere sollevato. Maestro è assai più di insegnante, di chi cioè mette solo il segno del sapere, in-signa, in un altro. L’insegnante può anche insegnare bene, ma non è detto che il suo insegnamento costituisca sempre e comunque una crescita formativa dello studente. Maestro va sicuramente oltre la funzione, direi giuridica, istituzionale, del docente che ha dinnanzi a sé il discente, titolare dell’altra funzione, quella di imparare. Per non parlare del professore, di chi pro, apertamente, fiteor, fessus, fiteri dichiara, annuncia, di colui che davanti agli scolari, semplici frequentanti della schola, annuncia un sapere, una verità, che va depositata, conservata, riferita, mai discussa perché ex cathedra.
Concludo, anche se il libro di Pennac stimola molte altre riflessioni, con l'augurio che il ministero della pubblica istruzione abbia il coraggio di farne dono al suo quasi milione di professori affinché leggendolo possano provare a diventare anche maestri.
lunedì 12 maggio 2008

è un libro molto bello, il terzo di una fortunata trilogia fantasy: "Queste Oscure Materie". parla di due ragazzi provenienti damondi diversi, Will e Lyra, che prendono parte alla lotta instaurata dal padre di quest'ultima contro l'autorità divina, allo scopo di costituire la Repubblice dei Cieli. è molto coinvolgente e affascinante.
domenica 11 maggio 2008
“L’uomo che non credeva in Dio” di Eugenio Scalfari – Mondadori, Milano 2008
 È un dono incontrare intellettuali intelligenti, di vaste letture, che hanno attraversato con te gran parte del tuo tempo accompagnandoti con le analisi, i giudizi, le considerazioni che spesso ritrovi già pensate da te, ma non ancora espresse con le parole chiare con cui le dice dalle colonne di un giornale. È il caso di Eugenio Scalfari, non solo giornalista, ora editorialista domenicale de la Repubblica, ma anche sapiente scrittore, che da tempo, anche con altre opere, va alla ricerca di una propria identità, di una sorta di definizione dell’io, del proprio io.
È un dono incontrare intellettuali intelligenti, di vaste letture, che hanno attraversato con te gran parte del tuo tempo accompagnandoti con le analisi, i giudizi, le considerazioni che spesso ritrovi già pensate da te, ma non ancora espresse con le parole chiare con cui le dice dalle colonne di un giornale. È il caso di Eugenio Scalfari, non solo giornalista, ora editorialista domenicale de la Repubblica, ma anche sapiente scrittore, che da tempo, anche con altre opere, va alla ricerca di una propria identità, di una sorta di definizione dell’io, del proprio io.Quest’opera di chiarificazione del Sé appartiene alla maturità dell’uomo: i grandi hanno avvertito il bisogno intimo di affrontare il passaggio della morte affidandosi al senso della propria vita, di ricercare in esso e solo in esso il viatico per varcare la soglia del mistero. Ad accompagnarci in quest’ultimo viaggio ci sono le persone vere, quelle in carne ed ossa, con cui si è condiviso il nostro tempo. Esse, a qualunque titolo l’abbiano intersecato, intrecciando la loro esistenza con la nostra, non possono essere rimosse. Non è facile regolare i conti con esse, specie se, come è il caso di Scalfari, in qualche modo si è esercitato un potere che ha potuto disporre del destino delle vite altrui.
Per un intellettuale di vaglia ci sono poi le letture, gli incontri con quei libri che ti formano le idee, che suggeriscono riflessioni, l’amore per quelle opere artistiche, musicali, di cui conservi le forme, i colori, le note, i significati delle interpretazioni. Infine il pensiero interrogante, per questo fondamentalmente filosofico, consapevole che le domande anche quelle più ruvide vanno sempre fatte, specie nell’età dei bilanci. E qui Scalfari, laico, illuminista, sicuramente anticlericale, fa i conti con la presenza scomoda di Dio. Non è il dio cha da piccino pregava accompagnando la mamma alle funzioni religiose, non è il dio di cui si sono appropriati gli apparati ecclesiastici, al contrario è una presenza assente, che egli prova a rintracciare insieme a Sant’Agostino e a Nietzsche.
Al primo è debitore di quel tormento che il credente prova di fronte al destino dell’anima: cosa (e non dove) essa sarà dopo la morte, cosa conserverà ad esempio della memoria che nel tempo l’ha formata. Davanti alla pagina che Scalfari riporta delle Confessioni lo spirito del laico resta in silenzio, come anche ammutolisce il credente pensando se stesso dinnanzi a Dio senza più la memoria di sé, senza più quel pensiero che da vivo glieLo ha fatto cercare. È un mistero sapere come si sarà davanti a Dio, cosa di quel che siamo sarà mantenuto, e più ancora se conserveremo quella parte migliore di noi che non si è arrestata di fronte alle evidenze, alle così dette verità rivelate, ma che ha cercato di capire anche ammettendo l’insufficienza del proprio pensiero.
Di Nietzsche rielabora in una chiave tutta personale, ma non per questo filosoficamente meno interessante, il celebre annuncio della “morte di Dio” riportato in Così parlò Zarathustra. L’evento di per sè è tragico, perché gli uomini uccidendo Dio, hanno rinnegato ogni valore assoluto, senza sostituire al Dio morto qualcos’altro che riempisse quel vuoto, perché la liberazione dalla verità precostituita ci ha consegnato la responsabilità di navigare in mare aperto senza più riferimenti. Insomma la morte di Dio mantiene tutto intero il problema di Dio. Si sposta l’ottica dal cielo alla terra; è qui nella natura, nel suo costituirsi come tale, come generatrice di se stessa che occorre scoprire ciò che si è perduto. Ecco perché non si può credere in Dio, tanto meno nel Dio della metafisica, della religione, di un Dio estraneo ed esterno all’essere del mondo nell’atto di crearlo. Forse nel riportarci al destino originario di dare senso al nostro essere e all’essere in generale, come dirà poi Heidegger, è possibile quella sconfitta della morte, dalla paura della quale principia ogni fede religiosa.
A più di ottant’anni Scalfari ci accompagna in questa ricostruzione di sé per farci partecipi del destino dell’essere di ciascuno, e lo fa con una scrittura che attinge a registri diversi che vanno dal linguaggio diaristico (quante memorie in questo libro!), alla riflessione filosofica, alla parola poetica, quasi a dire che in ciò di cui si conserva viva la memoria, nel pensiero dell’essere e nella parola sottratta all’usura della quotidianità e restituita al significato originario, pieno, come sa fare la poesia, è la possibile identificazione di sè. Ne voglio fornire un esempio in questo passo di pag.7
“Il tempo per noi passava in un lampo perché era gremito di fatti, anzi di eventi, memorabili soprattutto per me che ero il solo figlio unico di tutta quella vasta compagnia.
Quando è ricco di presenze e di avventure il tempo ti fugge dalle dita, un attimo incalza l'altro e lo spinge indietro nel passato mentre l'attimo futuro ti piomba addosso con la velocità della luce. Ma quando lo rivisiti nel ricordo quel periodo della tua vita ti sembrerà infinitamente lungo, a misura dei fatti e degli incontri che l'hanno costellato.
Incessante romba il tempo e incanutiscono i covoni della tua vita e non sai se sia lui a trasportarti o tu a condurlo verso la foce.”
Mi permetto un arbitrio, quello di trasformare l’ultimo paragrafo in questi versi:
“Incessante romba il tempo e
incanutiscono i covoni
della tua vita e
non sai
se sia lui a trasportarti
o tu a condurlo
verso la foce” .
P.S. Se qualcuno della tribù avesse voglia di leggere questo libro sarei felicissimo di prestarglielo.
della tua vita e
non sai
se sia lui a trasportarti
o tu a condurlo
verso la foce” .
P.S. Se qualcuno della tribù avesse voglia di leggere questo libro sarei felicissimo di prestarglielo.
giovedì 8 maggio 2008
“La solitudine dei numeri primi” di Paolo Giordano – Mondadori, Milano 2008
 I numeri primi in matematica sono quei numeri naturali positivi, divisibili per se stessi e per l’unità. Ci sono poi coppie di numeri primi, vicini tra loro, separati solo da un numero pari, per esempio l’11 e il 13, il 17 e il 19, che i matematici chiamano primi gemelli. In questo primo romanzo di Paolo Giordano, i numeri primi sono due ragazzi straordinari, veramente fuori dell’ordinario, così diversi dal mondo dei loro coetanei da esserne respinti o tenuti a distanza, o per loro scelta viverne ai margini.
I numeri primi in matematica sono quei numeri naturali positivi, divisibili per se stessi e per l’unità. Ci sono poi coppie di numeri primi, vicini tra loro, separati solo da un numero pari, per esempio l’11 e il 13, il 17 e il 19, che i matematici chiamano primi gemelli. In questo primo romanzo di Paolo Giordano, i numeri primi sono due ragazzi straordinari, veramente fuori dell’ordinario, così diversi dal mondo dei loro coetanei da esserne respinti o tenuti a distanza, o per loro scelta viverne ai margini.Lei, Alice, a sette anni, ha un incidente alla scuola di sci, che frequenta solo per obbedire al padre. Il corpo conserverà per sempre la cicatrice di quella gamba spezzata, e l’anima, a stento e a caro prezzo, riuscirà a liberarsi e a riscattarsi dall’obbedienza sottomessa, priva di un qualsiasi slancio di ribellione, che accompagnerà la sua adolescenza.
Lui, Matteo, è gemello di una sorellina con un marcato handicap mentale, della quale involontariamente, provocherà la morte. La sua intelligenza concentrata solo sul calcolo matematico e la sua sensibilità troppo distratta per concedersi agli affetti ne fanno un numero primo (si avvia ad una brillante carriera di matematico in un’università nordeuropea) che cercherà di spezzare il muro della solitudine che è venuta erigendosi attorno alla sua vita.
Le loro vite si sfiorano senza mai intrecciarsi; si sostengono reciprocamente, sanno di poter contare l’uno sull’altra senza che questa fiducia diventi un legame di affetti. E nella pagina finale del romanzo Alice, la più fragile, la più esposta alle delusioni della vita, sorride verso il cielo terso. Con un po’ di fatica anche lei sa alzarsi da sola.
La solitudine dei numeri primi è l’opera prima di un giovane laureato in fisica teorica e che lavora presso l’università di Torino con una borsa di dottorato, dotato di una scrittura efficace che ti prende e coinvolge. È sicuramente uno dei romanzi più interessanti che ho letto di giovani scrittori italiani.
giovedì 1 maggio 2008
“Il campo del vasaio” di Andrea Camilleri – Sellerio, Palermo 2008
 Il campo del vasaio è quel terreno che gli uomini del Sinedrio acquistarono con i denari di Giuda, pentito del suo tradimento di Cristo. E’ un luogo di sangue (lì fu sepolto l’apostolo traditore dopo essersi impiccato) e di tradimento, e sangue e tradimento sono i perni attorno ai quali ruota l’indagine del commissario Montalbano in questo nuovo romanzo di Camilleri. L’omicidio che fa da filo conduttore alla storia è apparentemente un delitto di mafia; chi lo ha commesso ha seguito un rituale nelle apparenze riconducibile alla cultura degli uomini d’onore. Ma le cose non stanno così. C’è meno onore e più disonore, c’è meno fedeltà e più tradimento in questo delitto. Ed è ragionando sulle apparenze, sulla loro intenzionalità reale, che Montalbano svolge la paziente opera dell’inquirente che demistifica prima di consegnare al lettore la verità.
Il campo del vasaio è quel terreno che gli uomini del Sinedrio acquistarono con i denari di Giuda, pentito del suo tradimento di Cristo. E’ un luogo di sangue (lì fu sepolto l’apostolo traditore dopo essersi impiccato) e di tradimento, e sangue e tradimento sono i perni attorno ai quali ruota l’indagine del commissario Montalbano in questo nuovo romanzo di Camilleri. L’omicidio che fa da filo conduttore alla storia è apparentemente un delitto di mafia; chi lo ha commesso ha seguito un rituale nelle apparenze riconducibile alla cultura degli uomini d’onore. Ma le cose non stanno così. C’è meno onore e più disonore, c’è meno fedeltà e più tradimento in questo delitto. Ed è ragionando sulle apparenze, sulla loro intenzionalità reale, che Montalbano svolge la paziente opera dell’inquirente che demistifica prima di consegnare al lettore la verità.Mai però Camilleri confina Montalbano esclusivamente nel ruolo dell’investigatore. Gli assegna anche il compito di giudice, certo non del giudice delle aule giudiziarie, quanto di chi ha il forte desiderio di capire le trame della vita, che va oltre l’accertamento della verità poliziesca. Non c’è solo l’urgenza dell’uomo di legge di assicurare alla giustizia il colpevole, ma in lui opera una filosofia di vita che gli consente di attraversare le miserie, le passioni, gli intrighi dell’universo umano, e portarle alla luce perché siano da lui, insieme al lettore, giudicate.
E questo spiega perché la Vigata di Camilleri non è mai una società ripetitiva, ordinata e strutturata come un universo immobile. Al contrario è un variegato mondo in cui si rispecchiano pezzi notevoli dell’Italia di oggi della politica, dell’economia, del costume, della illegalità diffusa e di quella organizzata, della cultura, delle istituzioni, della Chiesa. Ogni romanzo è una finestra che si apre sull’Italia contemporanea, vista dalla Sicilia, come se questa costituisca una sorta di punto di osservazione privilegiato per capire quanto accade nel resto del paese. E’ il debito che Camilleri sente di dover pagare alla sua terra. La sua sicilianità non è solo una tecnica narrativa, il modus vivendi dell’ambiente e della storia narrati, una sorta di adesione alla lingua d’origine, ma è anche un modus osservandi, un modo di vedere le cose, per darci un’immagine vera, attendibile del nostro paese e della Sicilia. In questo modo Camilleri contribuisce al riscatto della Sicilia che avverte come compito assegnato a se stesso: presentare l’altro volto di questa terra, sottratto alla mafiosità, e costituito di gente pulita, onesta, che crede nella giustizia.
Nell’incubo notturno, con cui si apre il romanzo, è Catarella, l’agente semplice, quasi imbranato del Commissariato di Vigata, a minacciare di morte Montalbano, qualora egli accetti l’invito di Totò Rijna, divenuto nuovo capo del governo del paese, a fare il ministro dell’interno. Catarella che minaccia il suo commissario è la voce di quella coscienza onesta che salva Montalbano da un possibile tradimento. E’ la stessa voce che prende forma di dialogo interiore quando un Montalbano uno, più logico, razionale, freddo, calcolatore discute animatamente con il Montalbano due, sentimentale, accomodante, buonista.
Concludo questo breve assaggio sulla mia predilezione per Camilleri, che non esclude anche valutazioni di segno diverso, nella speranza che altri lettori, ai quali raccomando vivamente questo romanzo possano avviare un interessante dibattito sull’autore e la sua opera.
venerdì 18 aprile 2008
Iscriviti a:
Post (Atom)
